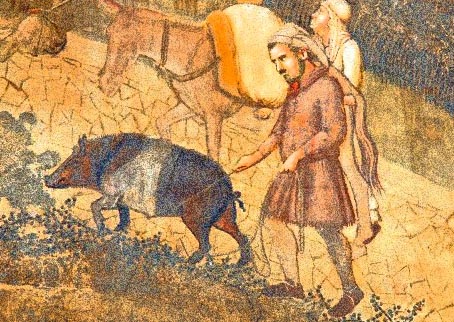L’affidamento diretto di un bene pubblico – senza alcuna procedura comparativa – costituisce un’aperta violazione ai principi generali della contrattualistica pubblica che impongono da una parte, la redditività dei beni (con una conseguente entrata all’erario), dall’altra, una procedura aperta e trasparente (in piena aderenza alla disciplina comunitaria, deve intendersi «concorrenza»)[1].
Non va sottaciuto che secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, soltanto in presenza di beni demaniali o del patrimonio indisponibile, si impone il ricorso a procedura di concessione di beni, nel mentre di norma il rapporto avente ad oggetto il godimento di bene immobile compreso nel patrimonio disponibile si qualifica in termini privatistici[2]; di converso, la natura patrimoniale disponibile del bene pubblico discende che l’attribuzione in godimento a soggetti terzi venga effettuata secondo le categorie negoziali di diritto comune[3], non esimendo l’Amministrazione (in entrambi i casi) da una procedura di gara.
Continua a leggere